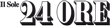Lavoro e professione
Diagnostica di laboratorio e farmacia dei servizi: quale modello possibile per coniugare appropriatezza clinico-diagnostica e sostenibilità
di Ettore Capoluongo * e Marcello Ciaccio **
24 Esclusivo per Sanità24

A partire dal primo test di gravidanza rapido introdotto negli anni ’70, la pandemia ha sicuramente dato una forte spinta all’ampia diffusione dei test rapidi. A oggi, sono disponibili numerosi dispositivi per il dosaggio di svariate molecole, dal glucosio, al colesterolo, agli ormoni tiroidei, ai marcatori cardiaci e, perfino, il sangue occulto nelle feci e la ricerca di agenti patogeni nelle feci, oltre che i tamponi faringei rapidi. Tuttavia, bisogna sottolineare e non sottovalutare che all’apparente vantaggio del cittadino di poter monitorare e analizzare in modo semplice e rapido il proprio stato di salute, in realtà si associano numerosi potenziali gravi rischi.
Innanzitutto, si deve considerare l’importanza dell’appropriatezza nella scelta dell’esame da eseguire: la farmacia non può essere considerata come un punto di diagnosi. Infatti, l’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per garantire il migliore risultato rispetto a uno specifico quesito clinico che deve essere formulato dal sanitario dopo un’attenta visita e valutazione dell’individuo, mentre i risultati di esami richiesti senza un razionale riducono significativamente l’accuratezza diagnostica per effetto della ridotta prevalenza, come ben descritto in qualsiasi trattato di statistica medica.
L’appropriatezza rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale per realizzare una medicina efficace ed efficiente: essa è proprio il primo principio di qualità dettato anche dalla norma Iso15189, che valuta un test come erogabile solo clinicamente utile/valido. La norma Iso15189 ha un ulteriore livello di assunzione: quello della competenza, che è il criterio fondamentale attraverso il quale si riconosce la qualificazione ad erogare una procedura diagnostica di laboratorio. Questo è anche lo spirito del recente regolamento europeo, il Regolamento Ue n. 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation, “Ivdr”), che prevede alti standard per tutti i presidi diagnostici ed una standardizzazione del livello di acquisizione di reattivi e software a fini diagnostici.
Riusciranno le farmacie ad assicurare tali standard, che vanno oltre il livello di qualificazione del personale, ma che partono dalla necessità di saper discriminare ciò che è clinicamente utile da quello che è commercialmente disponibile? Tali valutazioni possono essere fatte solo in presenza di professionisti di laboratorio, che in linea con le raccomandazioni e linee guida scientifiche è tenuto a rimodulare l’offerta di test diagnostici in linea con le nuove evidenze scientifiche: è questa una parte del lavoro del professionista di laboratorio.
Un altro aspetto fondamentale da sottolineare è la corretta interpretazione del dato di laboratorio e il conseguente corretto referto. Il dato di laboratorio non dev’essere considerato un semplice numero, come quello che viene fuori dai semplici strumenti utilizzati nelle farmacie, ma va corredato da informazioni sui livelli di normalità che variano a seconda della popolazione, del sesso e dell’età dei soggetti e deve essere sempre valutato ed interpretato in relazione alle caratteristiche cliniche ed anamnestiche dell’individuo, oltre che nel rispetto delle modalità di prelievo che sono parte fondamentale del processo diagnostico di laboratorio.
È, quindi, fondamentale definire le modalità di refertazione dei test rapidi e assicurarsi che il dato verrà correttamente utilizzato ai fini clinici, ancor più in considerazione del fatto che molti di questi dati contribuiscono alla costruzione del fascicolo sanitario elettronico del paziente. Questo aspetto, ancora una volta, rappresenta il ruolo dello specialista di laboratorio e richiede conoscenze e competenze proprie dei professionisti della Medicina clinica e della Medicina di laboratorio.
Si deve evitare che il cittadino, sulla base di una potenziale autodiagnosi, formulata anche con il supporto del “Dr. Google”, possa decidere quali esami eseguire e sulla base del risultato stabilire una autodiagnosi, anche perché un’autodiagnosi errata può comportare un trattamento inappropriato con gravi conseguenze per la salute e per lo stato psicologico stesso del soggetto.
Ogni esame, inoltre, deve essere effettuato con specifiche strumentazioni e con metodiche che assicurano la qualità del parametro analizzato: anche per il follow up di un biomarcatore bisogna sempre riferirsi allo stesso laboratorio per valutare in modo coerente il miglioramento dello stato di salute del paziente (riduzione dei livelli glicemici o dell’emoglobina glicosilata, piuttosto che un marcatore tumorale).
I limiti dei test rapidi. Aspetto fondamentale, infatti, è la qualità del dato ottenuto con i test rapidi, ovvero mediante i sistemi Point of Care Testing (Poct), che hanno, per natura, delle prestazioni adeguate per un autocontrollo e per il monitoraggio di alcuni parametri (ad esempio la glicemia) ma determinano prestazioni inadeguate per la diagnosi di malattia. A causa delle potenziali gravi conseguenze derivanti dall’uso di risultati non attendibili degli esami di laboratorio, è fondamentale la corretta gestione dei sistemi Poct sottoponendoli a costanti controlli di qualità e manutenzione. A tal fine, le analisi in Poct dovrebbero essere sempre eseguite sotto la responsabilità dei professionisti di Medicina di laboratorio, come accade nella maggior parte degli ospedali, che dovrebbero stabilire le modalità d’uso, le procedure per la verifica di qualità e la formazione degli operatori, oltre che il monitoraggio continuo delle performances dei test e delle apparecchiature.
Il tema della sostenibilità per il Ssn e della formazione dei professionisti. Le criticità rappresentate non solo sono potenzialmente dannose per il cittadino che ne usufruisce ma anche costituire una spesa inutile con aggravio per la sostenibilità del nostro sistema sanitario.
Il ricorso ai test in farmacia sarebbe una perdita culturale oltre che economica per il mondo medico-scientifico: porterebbe a un extracosto per ripetizioni, per rischio di overdiagnosi ed overtreatment generato da risultati potenzialmente non veritieri, se eseguiti senza il controllo da personale adeguatamente qualificato e non in grado di interpretare il valore di quel test, generando il rischio di fornire al paziente informazioni non valide.
Per arrivare a questa maturità professionale, si studia circa 10 anni tra laurea e specializzazione, si deve acquisire con la pratica in laboratorio tutta una serie di competenze per raggiungere quelli che, da contratto, rappresentano anche i livelli di inquadramento professionale che permettono a un dirigente sanitario ospedaliero di venire classificato a media, alta, altissima specializzazione, permettendogli poi di passare eventualmente a responsabile di Uos (unità operativa semplice) o Uosd (unità operativa semplice dipartimentale), fino a poter ambire, dopo almeno sette-dieci anni di professionalizzazione, alla posizione di Direttore di struttura complessa. In questo percorso, l’abilitazione del dirigente sanitario neoassunto a operare in una struttura sanitaria pubblica o accreditata, passa attraverso un periodo di formazione che prevede la compilazione della scheda di maturazione degli skill che lo renda in grado di refertare dagli esami più semplici a quelli più complessi (sempre che ne sia dimostrata la capacità). I sistemi di accreditamento e certificazione a cui non siamo obbligati ad adeguarci prevedono che venga stilato per ciascun dipendente un fascicolo della formazione che comprenda tutta la valutazione di acquisizione degli skills, oltre che l’ottenimento annuale obbligatorio dei crediti Ecm (requisito obbligatorio): senza gli Ecm, il professionista può andare incontro a sanzioni disciplinari fino alla sospensione dal servizio, se emerge che il Dirigente sanitario o il tecnico di laboratorio non hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dalla legge. E questo è solo una o dei tanti aspetti di cui ci si fa carico sotto il profilo della qualificazione delle competenze professionali dei professionisti di laboratorio. A tutto questo si aggiunge anche l’obbligo di effettuare le nostre prestazioni in ambienti idonei, adeguati, salubri, ergonomici, nel rispetto delle norme di sicurezza: da quelle più semplici fino all’antincendio. Oltre a questi “must”, bisogna anche obbligatoriamente ottemperare (pena la perdita della certificazione, e dell’accreditamento istituzionale) ai programmi di controllo di qualità interno (CQI) o esterni (VEQ) che, vanno superati e documentati agli ispettori nei diversi audit. Ogni esame di laboratorio refertato ha un mondo di procedure, azioni, interventi specialistici (commento al referto, ad esempio) che lo sottende: tutte queste fasi hanno una tracciabilità digitale che permette sempre di ricondurre agli operatori eroganti il test di essere chiamati in causa nel momento in cui qualche risultato venisse contestato.
Su queste basi si è costruita la piattaforma di messa a punto anche del fascicolo sanitario elettronico che è oggi alimentato prevalentemente dagli esami di laboratorio. Per arrivare a questa implementazione, abbiamo dovuto certificare i percorsi di presa in carico dei flussi di analisi diagnostiche che restano sempre riconducibili ad uno o più professionisti qualificati di laboratorio.
L’esperienza emergenziale del Covid non può trasformarsi di fatto nel paradigma della disfatta della medicina di laboratorio che si vedrebbe trasformata in un mercato libero dell’autodiagnosi dove si fa finta, in farmacia, di far eseguire al paziente tutto da solo, mentre una persona con un camice (che non si sa che qualifica abbia) fa finta di guardare un test che va avanti da solo. Non si può svilire il valore del test di laboratorio in questo modo, ancor più se si pensa che la diagnostica di laboratorio partecipa al 70% del percorso di diagnosi e cura di ogni paziente e interviene in modo scientifico anche nelle strategie di prevenzione e nella medicina di precisione.
Chi paga e con quale modello possibile? Il problema non è solo la delega al “fai-da-te”, ma è anche quello di verificare a carico di chi tutto questo accadrà. In un momento in cui: a) i nuovi Lea abbattono le tariffe della gran parte dei test diagnostici; b) si fa fatica nel pubblico, oltre che nel privato, a richiedere degli upgrade tecnologici, spesso elemosinando aumenti di budget per portare l’innovazione tecnologica a favore dei pazienti); c) si hanno problemi a reperire risorse di personale qualificato, che sarà sempre meno se il Pnrr sarà porterà a termine l’attivazione di tutti gli ospedali di comunità o delle strutture assistenziali decentrate sul territorio; d) le scuole di specializzazione dell’area di laboratorio vedono sempre meno vocazione proprio per le poche risorse disponibili nella diagnostica, ci chiediamo tutti con quali risorse le farmacie dovranno o potranno erogare servizi.
Se a carico del Ssr/Ssn, dovranno obbligatoriamente adeguarsi agli standard previsti per i laboratori pubblici e privati, sia per la dotazione di spazi che per l’organico professionale: dovranno partecipare ai controlli regionali e nazionali/internazionali Veq, certificare i percorsi e creare una infrastruttura informatica in grado di dialogare con il fascicolo sanitario elettronico.
Al paziente non dovrà essere più permesso di uscire dalla farmacia con uno scontrino di carta autorefertato e autodiagnosticato e ci dovrà essere, se eseguito su uno strumento per diagnostica decentrata (Poct), un sistema in rete di controllo delle performance strumentali e del test stesso. Se di questo si parla, solo i professionisti di medicina di laboratorio possono garantire questo percorso. Questa assunzione in realtà è legittimata dall’imminente partenza con le farmacie dei servizi in Lombardia dove, da giugno, le farmacie mettono a disposizione le proprie apparecchiature per consentire ai cittadini di effettuare holter pressorio, holter cardiaco ed Ecg grazie alla telemedicina. Ciò vuol dire che lo specialista di branca (il cardiologo) referterà gli esami diagnostici. Pertanto, anche gli esami di laboratorio dovranno essere refertati da uno specialista della branca di pertinenza. Se il modello prevedesse questo, le società scientifiche di laboratorio e l’Accademia dei settori disciplinari di medicina di laboratorio, non avrebbero difficoltà a supportare l’implementazione di tale progetto, immaginando che la regia della diagnostica di prossimità fatta in farmacia venga di fatto organizzata, standardizzata ed armonizzata dagli specialisti di laboratorio, permettendo al paziente di riferirsi alla farmacia più vicina per effettuare test controllati e validati da personale qualificato. Ovviamente, per far questo servirebbero ulteriori risorse: di questo, non vi è traccia in nessuno dei piani visionati al momento, mentre invece sono state tagliate significativamente prestazioni diagnostiche e le relative della gran parte di quelle approvate nei nuovi Lea. Le Regioni in piano di rientrano rischiano di non poter erogare a carico del Ssr le nuove prestazioni e di non poter prevedere la revisione delle tariffe di quelle più importanti.
Un’altra domanda che sorge spontanea è la seguente: ma il budget eventualmente dato alle farmacie eroderà quello già risicato e continuamento oggetto di tagli feroci delle strutture pubbliche/private convenzionate?
Le conseguenze di eventuali errori diagnostici. È stato calcolato quanto impatterebbe l’overdiagnosi o l’errore diagnostico sulla richiesta di accesso a cure ed esami strumentali e di laboratorio nelle strutture pubbliche, per effetto di questo accesso libero alla autodiagnosi in farmacia, ancor più se eseguita privatamente? Il paradosso è che il Ssn si vedrebbe ribaltare richieste di accertamenti a carico della comunità per erorri diagnostici relativi ad esami effettuati in autoprescrizione e in solvenza.
Solo una forte sinergia tra laboratori hub/spoke pubblici/convenzionati e farmacie territoriali potrebbe, invece, garantire un percorso in linea con gli standard di riferimento, non ultima la imminente implementazione dell’Ivdr a livello europeo, al fine di decentrare in farmacia la fase tecnico-analitica ma di tenerla sotto il controllo del personale di laboratorio, che si prenderà cura della corretta esecuzione oltre che dell’appropriatezza della gestione dei risultati e della comunicazione all’utente delle richieste. In tale scenario, le farmacie dovranno essere un dei tanti spoke per i pazienti/utenti che non trovano nelle vicinanze deli loro luoghi di residenza un ambulatorio prelievi o un laboratorio.
Questo modello, oggi, già si realizza all’interno degli ospedali dove, tutti i Poct (strumenti di diagnostica estemporanea rapidi), sono sotto il controllo del laboratorio: questo è diventato un obbligo di legge e molte regioni hanno già creato le reti dei Poct, sempre controllati dal laboratori di Asp, Asl o Aziende spedaliere.
Se si parla di un modello simile a questo, siamo pronti a contribuire al percorso avviato: se si tratta di sostituire quanto di grande i padri italiani della medicina di laboratorio hanno fatto per rendere questa disciplina un fiore all’occhiello nel mondo, allora siamo pronti davvero a scendere tutti in campo per ribadire la forza della nostra posizione critica.
Alla luce di queste considerazioni, in accordo alle dichiarazioni del dottor Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), emerge la necessità di un confronto multidisciplinare tra i vari professionisti coinvolti, inclusi i farmacisti e i medici, per definire e regolamentare un servizio che potrebbe essere prezioso per il cittadino, evitando di trasformarlo in uno strumento potenzialmente pericoloso con effetti negativi.
* Ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica, Università Federico II di Napoli; Direttore Uoc Patologia clinica Ospedale San Giovanni Addolorata - Roma; Componente dell’Expert panel on medical devices and in vitro diagnostics (‘Expamed’) presso la Commissione Ue; Componente “Committee on Molecular Diagnostics (C-MD)”- Ifcc (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
** Ordinario Biochimica clinica e Medicina di laboratorio, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Palermo; Presidente Società italiana di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica – Medicina di laboratorio; Presidente del Collegio dei professori ordinari di Biochimica clinica; Direttore Dip.to e Uoc Medicina di laboratorio del Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo
© RIPRODUZIONE RISERVATA