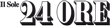Lavoro e professione
Contratti pubblici/ Il caso del Ccnl Area funzioni locali e lo strapotere del Mef
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24

Il personale del Ssn sta attraversando da troppo tempo situazioni di criticità assurde cui nessuno pone rimedio o, per meglio dire, “vuole” porre rimedio. Sono note e all’ordine del giorno le questioni relative ai medici e agli infermieri, intesi spesso come sineddoche impropria di tutto il personale sanitario. Le tematiche del disagio sono numerose: livelli retributivi del tutto insufficienti e grandi ombre di incertezza sul rinnovo 2022-2024, le crescenti difficoltà del reclutamento, il perdurante e infinito fenomeno delle violenze nei confronti degli operatori, la tentazione di abbandonare il servizio pubblico per contesti apparentemente più attrattivi. Gli aspetti ricordati – tranne il primo che riguarda indistintamente tutti - interessano sostanzialmente il personale sanitario. Tuttavia, la componente minoritaria, ma altamente strategica, della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo versa in una situazione di difficoltà peculiare e ai limiti dell’incredibile.
Premesso che i contratti collettivi del comparto e dell’Area della dirigenza sanitaria sono stati - faticosamente e con molti punti deboli - rinnovati rispettivamente il 22 novembre 2022 e il 23 gennaio 2024, si vuole fare qui riferimento all’Ipotesi del Ccnl della dirigenza dell’Area Funzioni Locali, sottoscritto dalle parti già in data 11 dicembre 2023, che per la specifica sezione dedicata ai dirigenti Pta interessa poco meno di 5.000 soggetti. Avevo già accennato al mistero che avvolge la questione nell’articolo pubblicato il 6 maggio scorso, ma ancora adesso nessuno è in grado di conoscere, anche ufficiosamente, i tempi dell’iter per la sua sottoscrizione definitiva. Risulta infatti che la Preintesa sia stata già da tempo trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma, a oggi, non risulta neanche calendarizzata la discussione: e dopo la deliberazione del Cdm, per arrivare alla sottoscrizione definitiva del testo si dovrà attendere in ogni caso il passaggio alle sezioni unite della Corte del Conti per la compatibilità dei costi contrattuali.
Stiamo parlando di un Ccnl che riguarda il triennio contrattuale 2019/2021 già scaduto da 30 mesi, tornata contrattuale peraltro conclusa e monetizzata per la quasi totalità dei dipendenti e dirigenti del pubblico impiego e che riguarda anni di forte perdita salariale a causa degli elevati tassi di inflazione. Ma quali solo realmente le ragioni di questo ritardo che ha ormai raggiunto i sei mesi, credo un record assoluto? A mio parere, il vero motivo risiede nella inadeguatezza del modello contrattuale vigente stretto tra una fase squisitamente privatistica e una successiva integrazione dell’efficacia di matrice pubblicistica, per molti versi incompatibile con il principio della libertà sindacale e con quello della discrezionalità delle autonome determinazioni delle parti negoziali. Ma se almeno questa fase rispettasse la legge la questione sarebbe circostanziata e, invece, questa latenza di sei mesi sembra violare tutte le regole fissate dallo stesso legislatore. In tal senso, basta leggere l’art. 47 del d.lgs. 165/2001 per capire che c’è qualcosa che non va. Il paradosso è che, prima delle modifiche apportate dal dlgs 150/2009 – il decreto delegato “Brunetta” che avrebbe dovuto semplificare la contrattazione collettiva – la stessa legge prevedeva l’efficacia della Preintesa per decorso dei termini dopo il 40° giorno dalla firma della Ipotesi (settimo comma dell’art. 47 previgente). Un principio di civiltà giuridica che conciliava la natura privatistica del Ccnl con i principi di finanza pubblica, ricorrendo tuttavia al silenzio assenso nel caso in cui in quei quasi due mesi gli organi preposti non fossero riusciti a segnalare i vizi. La nuova procedura introdotta nel 2009 potrebbe anche essere, in via del tutto teorica, più rapida dei 40 giorni del passato; senonché non è finita la pletora degli interventi, perché la Ragioneria Generale dello Stato nel 2018 ha elaborato unilateralmente una tesi - nota n. 54059 del 30 marzo 2018 non completamente condivisibile - che considera ancora obbligatorio un ulteriore parere del Consiglio dei ministri. Si tratta della previsione contenuta nel quarto comma dell’art. 47 del citato decreto 165 laddove si dice che per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale “fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’Aran”. Orbene, è vero che i decreti attuativi di cui sopra non sono mai stati ancora tutti adottati (o, meglio, come dice il Mef due decreti “non sono stati integralmente attuati”) ma di tale circostanza – di cui è colpevole in ogni caso soltanto il Governo – non può risentirne ancora dopo quindici anni il percorso definito dalla “riforma Brunetta”.
Per completezza di esposizione, si ricorda che la legge 42/2009 riguardava il federalismo fiscale e prevedeva una ventina di deleghe al Governo che dal 2011 al 2014 ha provveduto all’adozione di 12 decreti delegati e all’appello mancavano soltanto i decreti previsti dall’art. 23, comma 6, che concerneva l’istituzione di 9 Città metropolitane. Ma tale vicenda ha subito una svolta legislativa complessa in cui è intervenuta anche una sentenza della Corte costituzionale fino ad arrivare alla legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (“legge Delrio”) che ha previsto nelle Regioni a statuto ordinario l’istituzione di 10 città metropolitane, identificando la loro delimitazione territoriale con quella della relativa provincia contestualmente soppressa. Come si vede, il richiamo del Mef al non completamento del percorso della legge 42/2009 è pretestuoso e la stessa legge richiamata può ritenersi a regime per consentire l’abbandono dell’ulteriore parere del Consiglio dei ministri. Sul piano istituzionale appare piuttosto imbarazzante che un testo la cui stipula viene autorizzata dal Comitato di settore e che ottiene la certificazione positiva della Corte dei conti debba essere manipolato o cambiato per opera di un ulteriore soggetto pubblico; tutto ciò svilisce lo stesso controllo della Corte dei conti e fa perdere credibilità all’intero processo negoziale.
Sull’intervento del Mef si pongono due questioni, una di merito, l’altra di metodo. Riguardo alla prima si è già detto della forzatura normativa che porta avanti il Mef da sei anni. Sulla seconda si aprono scenari inediti perché ci si dovrebbe chiedere cosa potrebbe accadere nel caso in cui le parti negoziali non intendano ottemperare alle “indicazioni” governative. A tale ultimo proposito, si deve tenere conto che per tutta la fase della trattativa la Ragioneria Generale dello Stato risulta presente al tavolo negoziale e tutti i rilievi o indicazioni vincolanti dovrebbero per correttezza essere gestiti e risolti ex ante e non ex post a Preintesa siglata. Infatti, stante la natura privatistica del Ccnl, si dovrebbe ritenere che il “vero” contratto sia la Preintesa e negli anni Novanta i sindacati erano irremovibili nell’accettare qualsiasi modifica non negoziata e condivisa. Ma i tempi sono cambiati e il ritardo cronico dei rinnovi, la fretta di chiudere e la pressione della base sindacale hanno evidentemente indotto la controparte sindacale ad essere più condiscendente riguardo alle prese di posizione dell’Economia: d’altronde, la scelta tra subire una imposizione o mandare tutto a monte non è sempre facile. C’è da dire altresì che le “osservazioni” del Consiglio dei Ministri che recepiscono quelle del Mef non sono – o non dovrebbero essere - vincolanti perché non costituiscono una “autorizzazione” né un “controllo contabile” ma un mero parere. Già la formulazione è ambigua: dal verbale del Consiglio dei ministri leggiamo che “...ha espresso la valutazione positiva del Governo alle condizioni previste dalla nota del Ministero…”. Che succede se queste condizioni non vengono recepite dalle parti ? Non è dato saperlo; ma, considerato che l’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Governo per il tramite del Dipartimento della Funzione pubblica, non è difficile presumere che la situazione sia piuttosto delicata sul piano strettamente politico.
In questi ultimi anni si è dovuto attendere il Rapporto di certificazione della Corte dei Conti e vedere quali sarebbero state le conseguenti determinazioni. In ogni caso, l’ipotesi legale secondo la quale “il Presidente dell’Aran... provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo” è tassativamente prevista solo nel caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti: è meglio, quindi, non approfondire lo scenario che si sarebbe potuto aprire qualora le osservazioni del Governo fossero state ritenute vincolanti ma disattese dalle parti negoziali ovvero dalla controparte sindacale mediante il rifiuto della firma definitiva.
Gli interventi del Mef negli anni. Ricordiamo in breve le tematiche sulle quali in questi anni il Mef è intervenuto a gamba tesa, sovrapponendosi alla autonomia collettiva e ledendone a volte la libertà: tra le tante, le più recenti sono le propine degli avvocati (tematica che dovrebbe essere l’oggetto del contendere odierno), la inidoneità a qualsiasi attività lavorativa, la promozione sul campo di Oss e Autisti soccorritori, la imposizione dell’aggettivo “permanente” alla esposizione ai raggi, i tetti finanziari alle prestazioni aggiuntive dei medici. La prima problematica dell’elenco era già stata stravolta per volontà del Mef nel 2020 e fu probabilmente la prima volta che una clausola regolarmente negoziata e definita dalle parti fosse espunta dal testo. La formulazione stessa non lasciava dubbi sulla invasività. Il 2 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri ha dato parere favorevole al testo del contratto collettivo ma, su tassativa imposizione del Mef, ha condizionato il parere al “recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativa …..”. In altre parole, se al momento della sottoscrizione definitiva il testo contrattuale non avesse recepito l’emendamento dell’Economia, il Governo avrebbe ritenuto negativo il proprio parere. Con quale conseguenze? Nessuna, in pratica, perché Aran e sindacati hanno chinato il capo rispetto a una evidente lesione della autonomia collettiva. A volte c’è da chiedersi chi è che il realtà scriva i contratti collettivi.
Se il Mef utilizzasse la stessa puntuale, ossessiva rigorosità che mette in campo quando si occupa del pubblico impiego anche in altri ambiti istituzionali – che non è nemmeno necessario citare - le cose in questo Paese andrebbero meglio. Insomma, per passare quasi dal sacro al profano, viene da pensare a quella barzelletta in cui si chiede cosa mangia un gorilla di 300 chili e la risposta è: ma quello che gli pare, tanto chi gli dice niente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA