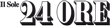Medicina e ricerca
Progetto Mnesys/ Dalla sclerosi multipla all’Alzheimer, il sistema immunitario “infiamma il cervello”. Il ruolo dei globuli bianchi e le due proteine spia della neuroinfiammazione
24 Esclusivo per Sanità24

Per molto tempo si è pensato che il sistema nervoso centrale fosse autonomo e che il cervello si difendesse da solo per la barriera encefalica che lo rende particolarmente resistente ad attacchi esterni. Si parlava infatti di “santuario immunologico privilegiato”. «Nell’ultimo decennio è però diventato via via sempre più evidente che così non è: il cervello e il sistema immunitario hanno un fitto dialogo, importante non solo per la difesa del cervello, ma anche per il suo funzionamento», spiega Gabriela Constantin, ordinaria di Patologia generale e Immunologia all’Università di Verona e coordinatrice dello ’Spoke 7’ di Mnesys, dedicato alla “Neuroimmunologia e Neuroinfiammazione”. Che «sta lavorando proprio per comprendere il coinvolgimento del sistema immunitario in malattie neurodegenerative, come la sclerosi multipla e l’Alzheimer, cioè tutte le patologie per cui l’infiammazione del cervello ha un ruolo solo recentemente individuato», precisa l’esperta.
In questo contesto si colloca la ricerca Re-emergence of T lymphocyte-mediated synaptopathy in progressive multiple sclerosis , accettata recentemente per la pubblicazione su Frontiers in Immunology, condotta dall’Università di Tor Vergata di Roma, che riguarda il ruolo dei linfociti T, cellule immunitarie fondamentali, nell’induzione della sclerosi multipla. Questo è una malattia autoimmune neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che colpisce circa 2,8 milioni di persone nel mondo, di cui quasi 130.000 solo in Italia. Nella sclerosi multipla i linfociti T si attivano in maniera anomala, vanno oltre la risposta autoimmune e danneggiano, così, i tessuti del sistema nervoso centrale causando un disturbo dell’attività delle sinapsi neuronali e quindi una disfunzione cerebrale. «Lo studio conferma che l’aggravamento della malattia, da una fase lieve con periodi di remissione a una fase cronica progressiva, è accompagnata da una alterazione funzionale dei neuroni a livello delle sinapsi, dove si verificano i contatti tra i neuroni e avviene la trasmissione dell’impulso nervoso, provocata proprio dalle cellule immunitarie - chiarisce Diego Centonze, ordinario di Neurologia presso l’Università di Roma Tor Vergata e direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia e della Stroke Unit presso l’Irccs Neuromed di Pozzilli -. Siamo inoltre riusciti a evidenziare come questa alterazione venga attenuata dal trattamento con Siponimid, un farmaco già attualmente in uso in pazienti con sclerosi multipla, enfatizzando quindi il ruolo dei meccanismi immuni nell’induzione del deficit cognitivo nelle malattie neuroinfiammatorie e neurodegenerative. Siponimid intrappola i linfociti negli organi linfoidi e impedisce quindi la loro entrata nel sistema nervoso dove provocherebbero danno, incluso quello alle sinapsi».
Un altro farmaco che riduce in maniera significativa gli effetti neurotossici indotti dai processi infiammatori a livello delle sinapsi è inoltre la molecola Interleuchina-9 come i ricercatori dello Spoke 7 hanno dimostrato nello studio Interleukin-9 protects from microglia-and TNF-mediated synaptotoxicity in experimental multiple sclerosis pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation a maggio 2024. «La ricerca dimostra che nella sclerosi multipla la somministrazione di questa molecola prodotta da una particolare categoria di cellule del sistema immunitario, riduce l’infiammazione dannosa caratteristica della sclerosi multipla indotta dalle cellule microgliali, cioè quelle cellule che si occupano della prima e principale difesa immunitaria attiva nel sistema nervoso centrale, e migliora la sintomatologia della malattia in modelli sperimentali», prosegue Centonze.
Il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale non solo nell’insorgenza della sclerosi multipla ma anche nella malattia di Alzheimer, come emerge dagli studi non ancora pubblicati condotti dall’Università di Verona nell’ambito dello Spoke 7 su questa patologia. «Le nostre ricerche stanno dimostrando come i globuli bianchi che circolano naturalmente nel sangue migrino nel cervello e si posizionino vicino ai neuroni, nelle zone importanti per la memoria – dichiara Constantin -. I nostri studi hanno evidenziato che questo fenomeno di migrazione leucocitaria ha un ruolo fondamentale nella malattia di Alzheimer e il suo blocco ha un effetto terapeutico, riducendo l’infiammazione cerebrale e migliorando la memoria. Mediante l’ausilio di studi in vitro, abbiamo infatti rilevato come le cellule immunitarie “aggrediscano” i neuroni inducendo un danno cellulare e l’alterazione dei circuiti neuronali. Queste ricerche indicano pertanto che i globuli bianchi possono indurre un danno diretto alle cellule del cervello e contribuire allo sviluppo dei deficit cognitivi», riferisce Constantin.
Lo Spoke 7 sta inoltre ricercando biomarcatori predittivi della malattie neurodegenerative, come emerge dagli studi guidati da Massimiliano Calabrese dell’Università di Verona Association of levels of cerebrospinal fluid Osteopontin with cortical atrophy and disability in early Multiple Sclerosis e CSF parvalbumin levels at multiple sclerosis diagnosis predict future worse cognition, physical disability, fatigue, and gray matter damage che presto verranno pubblicati sulla rivista Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation, nei quali si identificano due proteine che possono essere associate alla sclerosi multipla, presenti nel liquido cerebrospinale che avvolge il sistema nervoso centrale e che permette la diffusione di nutrienti e sostanze chimiche. «Abbiamo identificato l’osteopontina, una proteina coinvolta nel rimodellamento osseo con rilevanti azioni pro-infiammatorie, spia del calo numerico e funzionale dei neuroni e delle loro connessioni e della progressione della malattia in pazienti con sclerosi multipla in fase precoce. Inoltre, la presenza di un’altra proteina, la parvalbumina, all’esordio della malattia, è stata identificata come indicatore in grado di anticipare lo sviluppo di danno cerebrale a distanza di 4 anni. In particolare, livelli aumentati di parvalbumina nel liquido cerebrale hanno predetto il rischio di sviluppare atrofia cerebrale, deficit cognitivi, disabilità fisica e fatica cronica nei pazienti con sclerosi multipla», spiega Massimiliano Calabrese, professore di Neurologia dell’Università di Verona.
Tra i vari filoni di ricerca lo Spoke 7 sta inoltre anche indagando le forme di epilessia resistenti ai farmaci come nello studio The ferroptosis inducer RSL3 triggers interictal epileptiform activity in mice cortical neurons pubblicato su Frontiers in Cellular Neuroscience a giugno 2023. La ricerca si è focalizzata sul ruolo della ferroptosi, un nuovo tipo di morte cellulare programmata provocata dall’accumulo di ferro, nell’induzione di epilessia. «L’aumento della ferroptosi nel cervello è correlato a una disfunzione del sistema immunitario e caratterizzato da una reazione infiammatoria che potrebbe contribuire all’insorgenza dell’epilessia. È stato infatti dimostrato che la ferroptosi è coinvolta in questa malattia, in particolare nelle forme resistenti ai farmaci e comprenderne il meccanismo apre pertanto nuove strade per il trattamento dell’epilessia», afferma Enrico Cherubini, direttore scientifico dell’European Brain Research Institute Rita Levi–Montalcini (Ebri) e coordinatore del laboratorio congiunto Ebri - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù sulle forme di epilessia resistenti ai farmaci nei bambini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA