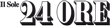Lavoro e professione
Contratto della dirigenza: le nuove regole su orario di lavoro e ferie si applicano anche agli universitari?
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24

Più volte ho segnalato quanto sia complessa l’applicazione del recente Ccnl della dirigenza sanitaria a causa delle notevoli revisioni introdotte negli aspetti organizzativi. Difatti le parti del contratto che riguardano istituti normativi o economici comportano difficoltà tutto sommato conformi a quelle pregresse e le modifiche e integrazioni costituiscono il normale lavoro sul campo derivante dai rinnovi contrattuali. Al contrario, le clausole che regolano orario, guardie, reperibilità, straordinario e ferie sono così innovative che necessitano di un diverso approccio rispetto al passato.
Un aspetto operativo forse non ancora valutato a pieno dagli addetti ai lavori è quello della applicabilità del Ccnl - ovvero di quali parti di esso - al personale universitario. Ricordiamo brevemente la peculiare e molto complessa situazione della convivenza di personale ospedaliero e universitario nelle aziende sanitarie che hanno questa caratteristica. Stiamo parlando del modello aziendale risalente alle norme contenute nel d.lgs. 517/1999, comunemente detto “decreto Bindi/Zecchino” dai nomi dei due ministri all’epoca in carica. Si tratta delle 36 “aziende ospedaliere integrate con l’università” (art. 2, comma 2, lettera b) che si distinguono dall’altra tipologia prevista dal citato decreto, cioè le 9 “aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale”, altrimenti denominate ex policlinici a gestione diretta (art. 2, comma 2, lettera a). Entrambe le tipologie giuridiche sono configurate nel richiamato art. 2, comma 2, del decreto e disciplinate dai successivi commi 3-10. I rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, con particolare riguardo all’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, sono determinati secondo specifici Protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio.
Le aziende ospedaliero-universitarie – perché così sono oggi chiamate tutte - utilizzano, come detto, organici dirigenziali costituiti sia da personale del Ssn che da docenti universitari. Ai primi, ai sensi dell’art. 2 del Ccnq del 10.8.2022, si applicano integralmente i contratti collettivi dell’Area della Sanità mentre i secondi, come è noto, non sono contrattualizzati e versano in regime di diritto pubblico, alla stregua di magistrati, avvocati dello Stato, militari e forze dell’ordine. I professori e ricercatori universitari che operano nelle Aou coprono parte della attività assistenziale della azienda, mantenendo il proprio stato giuridico e le norme legislative che lo disciplinano. Il lunghissimo art. 5 del decreto più volte ricordato detta le norme per l’integrazione dei docenti dell’organizzazione aziendale. Hanno tuttavia diritto, per la parte meramente assistenziale delle proprie prestazioni lavorative, ad un trattamento economico aggiuntivo previsto dall’art. 6, comma 1, che ha sostituito la pregressa cosiddetta “indennità De Maria”, dal nome del parlamentare pugliese Beniamino De Maria, prevista dall’art. 31 del DPR 761/1979 e, prima ancora, dall’art. 102 del DPR 382/1980. Per esemplificare i complessi aspetti in questione, si possono estrapolare alcuni concetti dal Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena (delibera di GRT n. 481 del 29.3.2005). Nel documento troviamo espressi principi quali “l’accettazione delle specificità dello stato giuridico e dei ruoli delle due componenti” o “il diritto al riconoscimento del trattamento aggiuntivo”. Tuttavia, nel documento si segnala anche che l’applicazione della normativa di riferimento recepita nel Protocollo “presenta difficoltà gestionali”.
E sono proprio queste difficoltà gestionali che sembrano essere oggi particolarmente complicate dall’entrata in vigore del Ccnl del 23 gennaio 2024. Un punto di partenza certo è il principio di legge secondo il quale “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”. Ma queste norme sono tutte senza distinzione, comprese quelle che non rivestono natura economica? È noto, ad esempio, che in materia disciplinare lo stesso decreto prevede una particolare procedura non direttamente gestita dall’Upd ma una segnalazione del Direttore generale dell’azienda. In particolare, alcune aziende si sono chieste se la applicazione del Ccnl del 23 gennaio 2024 sia automatica e scontata anche per il personale universitario e, ancora più in dettaglio, se l’art. 27 riguardante l’orario di lavoro sia applicabile indistintamente a tutti i medici che operano nelle strutture aziendali siano essi ospedalieri che universitari. Ricordo che il comma 3 dell’art. 27 ha introdotto una disciplina dell’orario di lavoro decisamente innovativa che è servita – o dovrebbe servire – a chiudere le annose vertenze relative alle eccedenze orarie. La possibilità di recuperare le ore prestate in più, situazione dovuta a “l’eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito ai sensi del primo periodo”, sembra un diritto che spetta anche al personale universitario, così come ad esso si applica l’algoritmo che definisce le ore dovute secondo quanto stabilito nel primo periodo dello stesso comma. Credibilmente il computo dell’orario non va effettuato sulle 38 ore ma su quelle assistenziali dovute secondo i Protocolli che, generalmente, sono 24 settimanali. Ma chi concede tali recuperi, l’azienda o l’università? La questione non è da poco perché la concessione di una quantità notevole di ore o giorni di recupero, seppure compatibile con le attività assistenziali, potrebbe intralciare le attività didattiche proprie dei professori e ricercatori. Analoghe perplessità sorgono riguardo alla eventuale monetizzazione delle ferie non fruite, tematica sulla quale dopo la sentenza della CGUe del 18 gennaio 2024 non sussistono in pratica più dubbi relativamente alla sua applicazione. Ma i docenti universitari godono di un regime di ferie completamente diverso dai colleghi contrattualizzati e, anche in questo caso, l’imposizione obbligata delle ferie e la loro eventuale successiva monetizzazione sono condizionate dalle compatibilità organizzative che per l’azienda ospedaliera sono solo quelle assistenziali e per l’università solo didattiche: per cui, quale dei due “datori di lavoro” colloca in ferie d’ufficio un professore o gli liquida la probabile monetizzazione ?
Le problematiche accennate - così come alcune altre - non possono che trovare soluzioni operative all’interno dei Protocolli o delle Convenzioni che regolano i rapporti Regione/Università che dovrebbero essere rivisitati e adeguati alla luce delle innovazioni contrattuali odierne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA